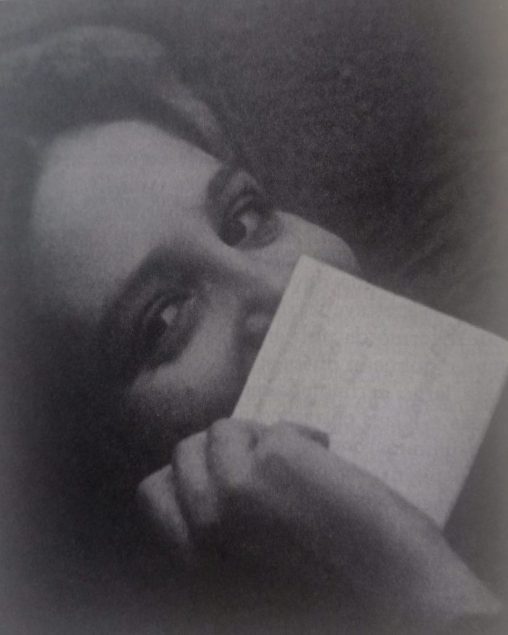di Alice Bada
“La prima considerazione che mi si presenta è sulla scrittura del libro. Pochi riescono a comprendere come nella scrittura si trovi la sola chiave di lettura di un testo e la traccia di una sua eventuale verità. Ebbene, la scrittura del Mare ha un che di esaltato, di febbrile, tende ai toni alti, dà nell’allucinato: e quasi in ogni punto della pagina presenta, pur nel suo rigore un che di <<troppo>>: sono palesi in essa tutti i segni di un’autentica <<nevrosi>>. […] Aggiungo che l’esperienza personale della guerra (terrore dovunque e fuga per quattro anni) aveva portato al colmo la mia irritazione contro il reale; e lo spaesamento di cui soffrivo era ormai così vero, e anche poco dicibile – perché senza riscontro nell’esperienza comune – da aver bisogno di una straordinaria occasione per manifestarsi. Questa occasione fu il mio incontro con la Napoli uscita dalla guerra. Rivederla e compiangerla non bastava. Qualcuno aveva scritto che questa Napoli rifletteva una lacera condizione universale. Ero d’accordo ma non sull’accettazione (implicita) di questo male. E se, all’origine di tale lacera condizione, vi era appunto l’infinita cecità del vivere, ebbene, era questo vivere, e la sua oscura sostanza, che io chiamavo in causa. Ero chiusa io stessa in quel nero seme del vivere, e perciò – tramite la nevrosi – <<gridavo>>. Anzi, gridai.” [i]
È il 53 quando, nel pieno della convalescenza dell’Italia dal trauma della guerra, viene pubblicata la raccolta di scritti “Il Mare non bagna Napoli”. Le fucine culturali del paese sono in fermento, mosse dall’entusiasmo laborioso di ricostruire le sue fondamenta minate dal disastro, che ha un impatto devastante soprattutto nelle realtà più povere e densamente popolate. In questo contesto i compagni della “Rivista Sud” commissionano ad Ortese la raccolta di prove documentarie dell’attuale situazione napoletana. Ma l’aspirante cronista è refrattaria a restare confinata nella categoria dell’articolo giornalistico, indossando ora la maschera del medico autore di referti psicopatologici del popolo, ora quello del voyeur che si perde in reportages impressionistici dei luoghi. Il criterio di realtà viene programmaticamente ir-rispettato, ma questo non implica la mancata volontà di aderenza al principio di verità. In effetti, come suggerisce la stessa Ortese, la chiave di lettura del testo non coincide con la sua apparenza contenutistica, ma è da rintracciare nell’ordito formale, in cui ne è racchiusa la radice più profonda. A distanza di quarant’anni dalla pubblicazione, si riapre la polemica sul “Mare”, sottoposto all’accusa di rappresentare una diagnosi distorta dello stato di salute della città. L’intellettuale Luigi Compagnone, ritratto come la personificazione del clima culturale esiziale che si respira, definisce “negromantico” l’acume critico di Ortese[ii]. L’accusata si sforza di rievocare le cause scatenanti all’origine del moto della scrittura del “Mare”, dichiara che la reazione di ribrezzo suscitata dall’incontro con quella realtà ha comportato una scelta radicale nella sua coscienza biografica e letteraria: quella di recidere ogni legame con l’ambiente d’origine e, contestualmente, con la dimensione del “reale”.
L’incontro con l’immagine di Napoli stravolta dalla guerra ha un impatto tale da indurla a riflettervi il suo “spaesamento” personale. Servendosi di una scrittura deformante, sfigura il volto della città a immagine e somiglianza della sua interiorità corrucciata, che vi si rispecchia. Napoli diventa la metafora incarnata della tragedia universale del reale, per cui Ortese comincia a provare un sentimento di “intollerabilità”. Ma questa spinta repulsiva scatena il moto reattivo della scrittura. È proprio nel “Mare” che ha inizio il processo di decostruzione della realtà rifiutata, funzionale alla costruzione della seconda realtà, oggetto di indagine dei successivi romanzi visionari. Nella favola parodica il “Cardillo addolorato” e nella falsa autobiografia “Il porto di Toledo” Ortese fa ritorno nei luoghi di Napoli trasfigurandoli con la sua lente immaginaria. Ma già il “Mare” è il cantiere di sperimentazione dei dispositivi formali della visione: il suo anomalo apparato ottico non le consente di limitarsi a vedere la città, ma a penetrarne l’essenza attraverso delle folgorazioni visionarie.
“Erano le mie testimonianze di una Napoli delle palafitte, dove era passata la mia stessa adolescenza; perciò, ricordai e confrontai con la Napoli <<storica>>, che adesso avevamo tutti sott’occhio, e scrissi buona parte, o almeno tracciai l’intero disegno, del mio libro su Napoli. Il quale dunque, fu visione dell’intollerabile, non fu una vera misura delle cose (di misure, ero e sono incapace).”[iii]
Solo ripercorrendo il disegno tracciato da Ortese, è possibile focalizzare il vero significato celato nelle insenature della scrittura del “Mare”. Il racconto “Un paio di occhiali” in apertura della raccolta è la lente ermeneutica da inforcare per leggere l’intera opera. Quello che appare come una narrazione dal taglio neorealista si rivela essere un apologo dall’attrattiva e dall’esaustività allusive-elusive di una parabola metaletteraria. Il destino di Eugenia, segnato dal suo drammatico incontro con la realtà, riflette specularmente il percorso della narratrice: la lente reale è la concretizzazione di quella virtuale della letteratura. L’immagine allegorica è il riflesso vitreo, in cui si materializza la consistenza della scrittura visionaria di Ortese: l’occhiale oggetto del desiderio, in vista del quale si costruisce la breve narrazione, è il referente della lente letteraria che ha per oggetto di osservazione il reale. Ma esercitare il privilegio di inforcare la lente è un gesto tracotante e periglioso: la vista del volto delle cose si svela un’esperienza trasgressiva al punto da risultare indigesta. O forse, la messa a fuoco del reale tradisce l’aspettativa che la desidera portatrice di un valore aggiunto e sottrae indebitamente l’occhio alla bellezza/pienezza contemplativa della visione? Lo schema narrativo calibrato è solo la chiave di lettura dell’eversiva conformazione ontologica di Ortese, portata attraverso il meccanismo di una scrittura deformante e nevrotica alle sue estreme conseguenze. Occorre quindi diagnosticare di quale difetto di vista è sintomo questa scrittura che crea effetti ostinatamente e ossessivamente visionari: un deficit indigente o un surplus indigesto di reale? Si tratta – secondo questa ipotesi – di un occhio ipermetrope che, vedendo oltre misura, non riesce a focalizzare l’oggettivo e quindi non può che trasfigurarlo. Ma il fenomenico a cui è esposto è già di per sé un abuso a cui si è assuefatto: la realtà è quella devastata dalla guerra a cui si sommano gli idoli spettacolari e populisti della napoletanità. E l’obiettivo della trasfigurazione visionaria è proprio quello di demistificare questi miti stereotipati, pericolosi.
“A distanza di qualche anno (era tanto che mancavo da Napoli), la famosa Riviera di Chiaia appariva un’altra. Una patina, misterioso intruglio di piogge, polvere e soprattutto noia, si era distesa sulle facciate, velandone le ferite, e riconducendo il paesaggio a quella immobilità rarefatta, a quell’espressivo, equivoco sorriso che appare in volto ai defunti. Forse, ove fosse mancata l’eterna folla di Napoli, semovente come un serpe folgorato dal sole, ma non ancora ucciso, tra quelle distinte apparenze di un’età remota, quel paesaggio non sarebbe apparso spettrale. Ma quegli uomini e donne e bambini seminudi e cani e gatti ed uccelli, tutte forme nere, sfiancate, svuotate, tute gole che ammettono appena un suono arido, tutti occhi pieni di una luce ossessiva, di una supplica inespressa- tutti quei viventi che si trascinavano in un moto continuo, pari all’attività di un febbricitante, a quella smania tutta nervosa che si impadronisce di certi esseri prima di morire, per un gesto che gli sembra necessario, e non è mai il definitivo – quella grande folla di larve che cucinava all’aperto, o si pettinava, o trafficava, o amava, o dormiva, ma mai veramente dormiva, era sempre agitata, turbava la calma arcaica del paesaggio, e mescolando la decadenza umana all’immutata decenza delle cose, ne traeva quel sorriso equivoco, quel senso di una morte in atto, di vita su un piano diverso dalla vita, scaturita unicamente dalla corruzione.”[iv]
Attraverso una deformazione iperrealista Ortese supera la retorica neorealista postbellica. Si tratta di un espediente simile alla re-invenzione poetica ed espressionista messa in atto da Pasolini in “Ragazzi di vita”. Il romanzo pubblicato nel 55, quasi coetaneo del “Mare”, descrive la Roma sovraffollata e disastrata del dopoguerra, non dissimile alla realtà napoletana sotto gli occhi di Ortese. Per de-funzionalizzare il codice neorealista (oggetto di un dibattito, che ne sta decretando l’esaurimento delle modalità espressive), entrambi attingono al repertorio iconografico e programmatico della tradizione del romanzo realista, ponendo come oggetto/soggetto della loro indagine speculativa il popolo. La folla dalla genuinità ferina e vividezza formicolante descritta nel capitolo “Oro a forcella” rimanda a quella dei tumulti milanesi. Il tolstojano “grande selvaggio nel seno della società” citato nel capitolo omonimo al romanzo borgataro romano, popola lo stesso ecosistema di quello degli affreschi corali di Ortese: la piattaforma non bagnata dal mare, metafora mobile da cui scaturisce il progresso della Storia, e come tale destinata all’estinzione, corrisponde alla comunità sottoproletaria, i cui esemplari vengono fagocitati dalla travolgente mutazione borghese. Dichiarando il prosciugamento immobile di ogni sostanza vivente, persino della “fiumana del progresso” dalla forza distruttiva, Ortese si spinge oltre. Scolpisce nella pietrificata “Riva di Chiaia” dal “volto di una defunta” il profilo urbanistico della Commare secca di Belli e Pasolini e ricalca nel quartiere dei Tribunali la pianta luttuosa del lazzaretto manzoniano. Si tratta della rappresentazione per mezzo di una scrittura ipertrofica di una realtà che Ortese constata essere atrofizzata.
Ma, se da innamorato sociologo di un mondo a margine avvolto da un’aurea amorale, Pasolini lo eleva a mitico stemperandolo con tinte elegiache e degradandolo con interferenze di registro comico, Ortese è completamente immersa in questa dimensione senza la mediazione di nessun filtro che le consenta di distanziarsene. È quindi consapevole di essere già aldilà del velo mitico, immersa all’interno del quadro dipinto e falsamente mitizzante di una Napoli anestetizzata dai fumi mistificanti e dalle tinte fosche della natura ingannatrice. Rifiuta di abbandonarsi all’antidoto voluttuoso di un’allucinazione sonnambula e, attraverso una scrittura documentaristica e lineare, cerca di prenderne le distanze critiche. Per questo a differenza di Pasolini sceglie di rifiutare la finzione letteraria del romanzo e si prefigge di aderire con i suoi reportages all’“apertura della letteratura alla cronaca dove è rifugiata la vita”. Ma l’esposizione restituita al lettore non si rivela essere quella nitida della scrittura bianca, testimone della cronaca narrativa della credibile Orano: l’operazione di Ortese, specularmente opposta a quella di Camus, genera però degli effetti che la dimostrano non meno lucidamente engagée. Se quella scrittura che pretendeva di essere limpida e rivelatoria si dimostra apertamente esibizionista di un’oscurità dolorosa, è però la rivelazione ostentata di questo mistero e l’esasperazione delle sue deformazioni mostruose a metterne in discussione lo statuto di verità, facendoli apparire talmente assurdi da indurre il lettore al rifiuto disgustato di darli per veri.
“Eravamo, o almeno lo ero io, in quello stato d’animo tra l’angoscia e la consolazione di chi, uscito da una casa di pena, ritrova la luce, l’aria, e in qualche modo la dolce libertà umana, un certo livello di vita, allorché un rumore confuso e dolente, di cui non si avvertiva con certezza il significato, oscillando tra il dolore e una sorta di straziato sollievo, attrasse la nostra attenzione. Saliva da uno dei piani inferiori, saliva dalle scale profonde alle quali in questo frattempo ci eravamo ravvicinate”[v]
Accogliendo l’eco dell’invettiva lanciata da Matilde Serao, Ortese procede nello “sventramento di Napoli”, spingendosi fin “dietro il paravento” dell’apparenza ipocrita. Perfettamente al centro dell’impianto progettuale del “Mare”, segue le orme della giornalista napoletana nella sua catabasi sotterranea nei “bassi” della città, elevati dalla trasfigurazione poetica di Ortese. “La città involontaria” che descrive presenta una fisionomia gemellare e complementare alla Napoli reale, fino a rendere labile la linea di confine tra il regno dei vivi e la sua necropoli. L’altra Napoli è al contempo l’Averno in cui si muovono le larve dei sopravvissuti e la placenta limbica in cui un’umanità allo stadio embrionale attende di vedere la luce della legittimazione sociale. Allo scopo di denunciare le condizioni di vita dei senzatetto ospitati dall’edificio del III e IV Granili, si abbandona ad una requisitoria nei confronti dell’attendismo cronico di un intervento sanificatore dai piani alti. La descrizione-referto della facciata testimonia l’atmosfera di serialità straniante, sintomo del grigiore dello stesso edificio-macchina burocratica in cui si perde l’anonimo K. L’impatto disambientale – disumanizzate è analogo a quello delle Scuole e di Donna Olimpia, residenze – deposito delle famiglie del Riccetto e Marcello. Ma, spingendosi oltre, Ortese si addentra in una visita immersiva e corporea: l’utero dell’edificio costituisce l’anima dell’architettura letteraria che edifica.
Lungo il continuum della scala che la visitatrice percorre durante il sopralluogo, possono essere disposte le due spinte eversive della scrittura ortesiana: una di menomazione degradante, l’altra di aggiunta trascendente. Questa apparente catabasi è sorprendentemente intervallata da spiragli mistici: lo stato larvale e disumano dei piani infimi genera il desiderio arioso di “nutrirsi di luce” come direbbe Weil. A superare la stringente opposizione polare tra la pesantezza del fondo e la luminosità del vertice sono gli interstizi di scrittura pulviscolare di marca lucreziana, raggi che penetrano e illuminano luoghi destinati comunque a restare in ombra, attraverso la penna impugnata dalla descrittrice, materializzazione dell’“ala alla seconda potenza che fa discendere senza pesantezza”. Questa polis architettonica in cui il discrimine tra illuminazione naturale e artificiale, la distinzione tra grido e rumore, l’alternanza tra giorno e notte vengono sovvertite, è forse la reazione involontaria di fronte alla consapevolezza dell’impossibilità di realizzazione concreta di un’altra polis ideale: quella utopica e ad essa speculare progettata da Campanella in “La città del sole”. La convivenza degli opposti all’interno dell’anima architettonica del Granili dimostra come occorra deviare la direzione dell’indagine da condurre. La vera diagnosi da effettuare non consiste nell’etichettare la scrittura visiva di Ortese come ipo o iper vedente, restando intrappolati in una dicotomia stringente, ma nel ragionare in termini inclusivi contemplando la compresenza di opposti (“troppo/poco”, “luminosità/oscurità”, “defunto/nascituro”) reciprocamente compensativi e irrisolti, riproposizioni della coppia alle fondamenta della struttura filosofica ortesiana “nulla-Utopia”. Si tratta della contraddizione percettiva che è alla base di ogni ricerca della bellezza/pienezza.
“L’indomani si levò una giornata poco limpida, eppure piena di riflessi abbaglianti, di una confusa, turbata luce. Da ogni parte salivano gridi di venditori, acuti e tristi. Dovevo abbassare gli occhi per andare avanti, tanta la luce che filtrava da quelle immobili nuvole era intensa. In quel doloroso splendore, le case di via Roma, l’antica Toledo, dove presi il 115 che mi avrebbe portata all’Arenella, a casa di Rea, sembrava lì per franare, come una montagna di tufo; i diecimila balconi e finestre scintillavano, e così le vetrine dei negozi, le insegne dei locali pubblici, le edicole dei giornali. Ma era uno scintillio solitario come di una città abbandonata. Era strano, ma questo che vedevo, per tanti aspetti non mi sembrava un popolo. Vedevo della gente camminare adagio, parlare lentamente, salutarsi dieci volte prima di lasciarsi, e poi ricominciare a parlare ancora. Qualcosa vi appariva spezzato, o mai stato, un motore segreto che sostituisce al parlare l’agire, al fantasticare il pensare, al sorridere l’interrogarsi; e, in una parola, dà freno al colore perché appaia la linea. Non vedevo linea qui ma un colore turbinoso, da farsi a un punto bianco assoluto, o nero. I verdi e i rossi, per la rapidità erano diventati marci; gli azzurri e i gialli apparivano sfatti. Solo il cielo a momenti viveva, e la sua luce era tale che bisognava farsi schermo agli occhi.”[vi]
L’ultima sezione “il silenzio della ragione” è il capolinea del viaggio/spaesamento attraverso il libro. Ortese è al contempo la conducente del tram che percorre i luoghi del “Mare”, responsabile dell’andamento sbandato e convulso del suo corso e la disorientata passeggera seduta all’angolo, che cerca di visualizzare il paesaggio frammentario e sfocato intravisto dal finestrino. La mancanza di un confine netto tra coscienza interna e ambiente esterno, l’atto di valicazione di quel limen percepito come discutibile e poroso, rende il paesaggio descritto proiezione di quello riflesso nello specchio deformante dell’interiorità di Ortese. Attraverso la sua scrittura, non si limita a scattare un’istantanea del volto di Napoli, ma una sua radiografia profonda e precisa. Il paesaggio appare solo il fondale dipinto di una messa in scena, in cui il popolo-burattino è inconsapevolmente manipolato. Occorre quindi squarciare il velo del sipario per accedere al nucleo pensante della seconda natura. Quello che le consente di farlo è il singolare funzionamento del suo organo critico-visivo, paragonabile a quella dell’occhio ipermetrope. A causa della sua conformazione schiacciata i raggi luminosi non vengono fatti convergere sulla superficie, ma oltre il piano retinico, il punto remoto diventa un punto virtuale e le immagini degli oggetti lontani si formano quindi più in profondità, mentre sulla retina si creano loro proiezioni confuse.
In effetti l’approfondimento della realtà operato da Ortese, ha gli esiti formali incorporei e folgoranti della stessa consistenza della luce. La sua iper-sensibilità le consente di giungere al cuore della verità, a partire da micro-impressioni sonore e visive: la sordità insensata del rumore della folla è tombale di fronte all’eloquenza riflessiva del silenzio della ragione; l’ostentazione della gestualità popolaresca è incomunicabile rispetto alla sincerità complice di uno sguardo; l’inconsistenza dei colori sgargianti è offuscata dalla purezza solida delle linee. Come Maria Zambrano si immerge nell’atmosfera storica di Madrid e presagisce le sollevazioni ondose del suo popolo[vii], anche Ortese si affida alle percezioni sensoriali per risalire alla coscienza lucida del logos. La necessità di sottoporre ossessivamente ogni dettaglio al vaglio critico della scrittura, è dovuto all’uso di questa lente come strumento insostituibile di assimilazione di una realtà traumatica e accettabile solo dopo essere stata ripensata. Svelando il meccanismo di funzionamento del suo anomalo apparato mimetico-visionario, Ortese intende educare alla comprensione umana e costruttiva del reale. Deformandolo genera nel lettore un effetto di straniamento tale da indurlo a ripensarlo. Il tramonto delle speranze allo spegnersi delle luci del “Mare”, non esclude un appello a ridestare il pensiero critico dal sonno in cui è piombato. Lo sguardo penetrante di Ortese sottopone il terreno partenopeo ad uno scavo stratigrafico fino a smuovere il suo humus più profondo.
“Non sapevamo dove saremmo andati, e non avevamo alcuna intenzione di andare in qualche posto. Ma una volta per le vie di Napoli, non potete fare a meno di muovervi in questa o quella direzione, senza alcun proposito. Di solito, giunti a Napoli, la terra perde per voi buona parte della sua forza di gravità, non avete più peso né direzione. Si cammina senza scopo, si parla senza ragione, si tace senza motivo, ecc. Si viene, si va. Si è qui o lì non importa dove. È come se tutti avessero perduto la possibilità di una logica, e navigassero nell’astratto profondo, completo, della pura immaginazione. Una cosa avvertivo, alla mia sinistra, dove camminava il ragazzo Prunas: ed era questa cosa un dolore così concreto, così smisurato silenzio, da costituire il solo contrappeso possibile alla dolce anarchia della terra. Da pochi momenti, dal breve colloquio al Gambrinus quel dolore si era fatto coscienza, lucidità, violenza. L’amico della ragione mi odiava, per le memorie che gli riportavo, per lo specchio che gli offrivo, concavo specchio, dove la sua giovinezza si deformava. Ed era ancora strano come, sotto quella specie di morte, quella vaga decadenza di pelle, sguardi, parole, io sentissi battere ancora, a colpi secchi, la vita. Il ragazzo di un tempo, vivo sotto quella morte, pensava.”[viii]
Note:
[i] : Anna Maria Ortese, da “Il <<Mare>> come spaesamento”, prefazione de “Il mare non bagna Napoli”, Adelphi:Milano, 1994, pag. 9-10.
[ii]: Della polemica sul “Mare” e del rapporto con il “Cardillo addolorato” parla Angela Borghesi nel capitolo “Napoli con parodia” del saggio “Una storia invisibile. Morante Ortese Weil”.
[iii]: Anna Maria Ortese, da “Le Giacchette grigie di Monte di Dio” postfazione de “Il mare non bagna Napoli”, Adelphi:Milano, 1994, pag. 175.
[iv]: Anna Maria Ortese, da “Il silenzio della ragione” contenuto in “Il mare non bagna Napoli”, Adelphi:Milano, 1994, pag. 101.
[v]: Anna Maria Ortese, da “La città involontaria” contenuto in “Il mare non bagna Napoli”, Adelphi:Milano, 1994, pag. 89.
[vi]: Anna Maria Ortese, da “Il silenzio della ragione” contenuto in “Il mare non bagna Napoli”, Adelphi:Milano, 1994, pag.138.
[vii]: Il riferimento è a “Il ritorno alla città” nell’autobiografia poetica “Delirio e destino”.
[viii]: Anna Maria Ortese, da “Il silenzio della ragione” contenuto in “Il mare non bagna Napoli”, Adelphi:Milano, 1994, pag.162-163.