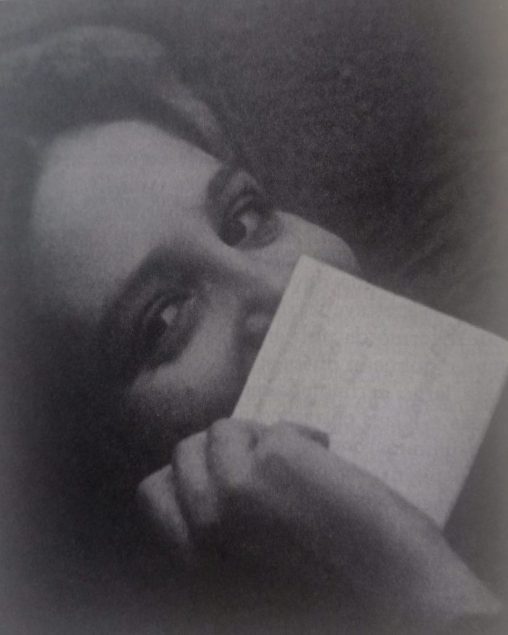
di Claudio Varsalona
“L’ultima innocenza” è il romanzo d’esordio di Emiliano Morreale, pubblicato da Sellerio e vincitore dell’opera prima al Campiello. Professore di storia del cinema e critico cinematografico, Morreale scrive un libro curioso, mosso da un quieto sperimentalismo e da un amore esibito fin sulle soglie del testo: quello per il cinema, l’ultima innocenza (il titolo) o la magnifica ossessione (il film da cui è tratta l’immagine della copertina). Una raccolta di sei biografie di attori e di registi, frammenti di vita in cui la pellicola sembra un fil rouge, organizzati poi da una narratore fittizio, un apprendista biografo – cinefilo, archivista e professore – che si affeziona ai suoi personaggi, tenta di riempire, attraverso una compassione ostinata, le parti bianche negli abbozzi delle loro vite.
Morreale riesce ad introdursi in un filone molto affollato della letteratura contemporanea, quello della testimonianza, del testo che nega il proprio carattere finzionale (i “libroidi” di cui parla Policastro1), ma allo stesso tempo se ne allontana, lo mette in crisi: un doppio movimento in cui i confini tra la realtà e l’immaginazione diventano mobili, a tratti permeabili. L’autore si prefigge una fedeltà assoluta al documento storico, alle ricostruzioni scientifiche, ma ne sottolinea l’instabilità mettendo in scena la ricerca – virtualmente infinita – di un narratore che attraversa luoghi e tempi del cinema (l’università, il festival, l’archivio, fino ad arrivare al cyber-spazio). In breve i personaggi storici diventano oggetti del desiderio, le loro vicende così aggrovigliate – romanzesche verrebbe da dire, tantoché sembrano meno credibili dell’avventura del biografo – si fissano in un simbolo letterario entro cui si agita un destino, un fatum moderno e tecnologico. Ed usiamo la parola latina per la sua polisemia, in quanto significa sia “destino” che “oracolo”: il cinema, e di conseguenza le vite che genera il suo campo di tensioni, sono appunto un oracolo da interrogare. Ma se la risoluzione del mistero resta inarticolabile e i corpi del passato s’inabissano in un punto vuoto, sottraendosi all’attenzione dei vivi, i giri attorno questi centri mancanti – siano essi più o meno vicini al nucleo – si rivelano significativi2.
“L’ultima innocenza” è un ode al cinema, all’incontro di sguardi che favorisce: e guardare significa istituire un certo rapporto con le cose, col mondo intero. Gli sguardi creativi del regista, degli attori, e poi gli sguardi “analitici” o “estetici” di noi spettatori, dietro davanti di lato: tutto intrecciato in un’opera ambigua ma compatta, una costruzione che annoda il visibile al non-visibile. E da qui si dipartono le varie prospettive sul cinema, le loro gradazioni, che possono essere riassunte in due concezioni antitetiche ma complementari: il film come doppio potenziato della vita, entelechia che salva (pensiamo al caso di Giuseppe Greco, alla sua ultima – ingenua quanto inquietante – opera dedicata al padre, il boss mafioso Michele); o film come rappresentazione chiusa in sé, negativo della vita che ci permette soltanto di dedurre qualcosa oltre lo schermo, una forza che spinge sotto l’immagine e la deforma (pensiamo al rifiuto di Anna di essere filmata, sottolineato dalle considerazioni della studentessa).
“C’erano i film della vita, certo, ma altri film erano anzitutto, irriducibilmente, film delle vite degli altri, o della vita di nessuno: disperate dichiarazioni dell’impossibilità di vedere la vita. Dietro il cinema, contro il cinema, era la vita. I film potevano non solo amarla e servirla ma offenderla, mancarla, ferirla. Un presagio, una tabe si insinuava in quelle immagini.”3
Andare al cinema, in un modo o nell’altro, rimane un’esperienza decisiva, modifica la nostra percezione, e Morreale riesce a comunicarne l’importanza presentando luoghi stratificati, in cui il cinefilo può riconoscere un faglia immaginifica (il Palazzo dei Papi che è anche – ma forse soprattutto – il cupo castello moresco nell’Otello di Wells), e corpi trasformati nel supporto che ne ha catturato il fantasma di luce (nella pelle di Dorothy si riconoscono “le imperfezioni […] che screziano le pellicole dopo più passaggi”4). E la riflessione sulla materialità dell’arte cinematografica, il senso di disorientamento a seguito dell’innovazione digitale, ci sembra lo strumento migliore per inquadrare il tipo psicologico del cinefilo, degli “uomini posseduti dalla stessa inspiegabile ossessione”5.
Creature umbratili, nostalgiche, riunite nel silenzio di un cineclub (il mitico Lubitsch di Palermo) o sperdute nei sotterranei di una cineteca, simili a quelli di un cimitero; e consapevoli tutti del carattere necrofilo6 del proprio amore: sanno che il passato è definitivamente passato – ogni fotogramma reca la traccia di una fine – ma sono meno cinici dei fotografi, nel caso questi non siano dei perfetti imbecilli. Il cinefilo si lascia illudere per il tempo della proiezione, simile all’amante che sogna l’amato ormai perduto: c’è qualcosa di grandioso e di straziante nella sua fedeltà, nella mania che si fa devozione. Accettare il logorio inesorabile della pellicola (e dunque della vita) significa assumere una determinata postura etica: scendere sì, sprofondare magari, ma senza viltà. Il digitale invece sembra tacere – nella sua freddezza intangibile – l’ultimo segreto, abolisce in maniera ottusa, quasi perversa, l’idea della morte e del dolore: il passaggio non è soltanto di tipo estetico o tecnico, ma si dimostra un trapasso antropologico, morale.
“Nessuno dei film che intorno a noi si realizzavano avrebbe mai emanato alcuno odore; le nostre mani non avrebbero potuto mai toccarlo; nessun film sarebbe mai invecchiato o bruciato. E anche quei corpi custoditi negli archivi la cui fragilità e bellezza era possibile avvertire coi sensi dovevano diventare, per essere ancora presenti agli occhi, una serie di numeri – finalmente pure, incorruttibili, algide immagini senza vita reale”7
Durante la pandemia, quell’ “apocalisse di seconda mano”8, ridicola nella sua monotonia per chi non ne ha subito le conseguenze dirette, durante questa noia forzata, allucinata da una labirintite, il narratore svela le ragioni del suo progetto: rovistare “nelle vite degli altri non avendone una”9, diventare per un momento un paladino di giustizia contro un “acido biografo”10. Un compito paradossale che lo avvicina al cuore di un’esistenza, gli permette di riflettersi in essa, nel sistema che costituisce con le altre indagate, mostrando talvolta enigmatiche simmetrie, intersezioni. Ma all’ultimo tutto si perde, manca la voglia di imparare (se effettivamente c’è qualcosa che le storie possono insegnare), si preferiscono gli oscuri richiami delle sirene digitali, lanciati da un mondo opaco in cui il movimento è impossibile, o meglio falso, ridotto ad una serie di foto, oscene in tutti i sensi: ALL’S WELL THAT ENDS WELL.
Note:
1: Ci riferiamo all’articolo pubblicato su Snaporaz: “Libroidi. Sui romanzi-testimonianza”.
2: Una struttura che ricorda – certo in una forma meno radicale – “la vera vita di Sebastian Knight” di Nabokov oppure, se dovessimo trovare un corrispettivo cinematografico, l’indimenticabile “Belluscone – Una storia siciliana” di Maresco.
3: Emiliano Morreale, L’ultima innocenza, Sellerio:Palermo, 2023, pag. 110
4: ivi, pag. 185
5: ivi, pag. 33
6: Suggestiva anche la parentela che rintraccia Virilio in “Guerra e cinema. Logistica della percezione” per cui la cinepresa ricorda il funzionamento di un’arma.
7: Emiliano Morreale, L’ultima innocenza, Sellerio:Palermo, 2023, pag. 62
8: ivi, pag. 171
9: ivi, pag. 172
10: ivi, pag. 183