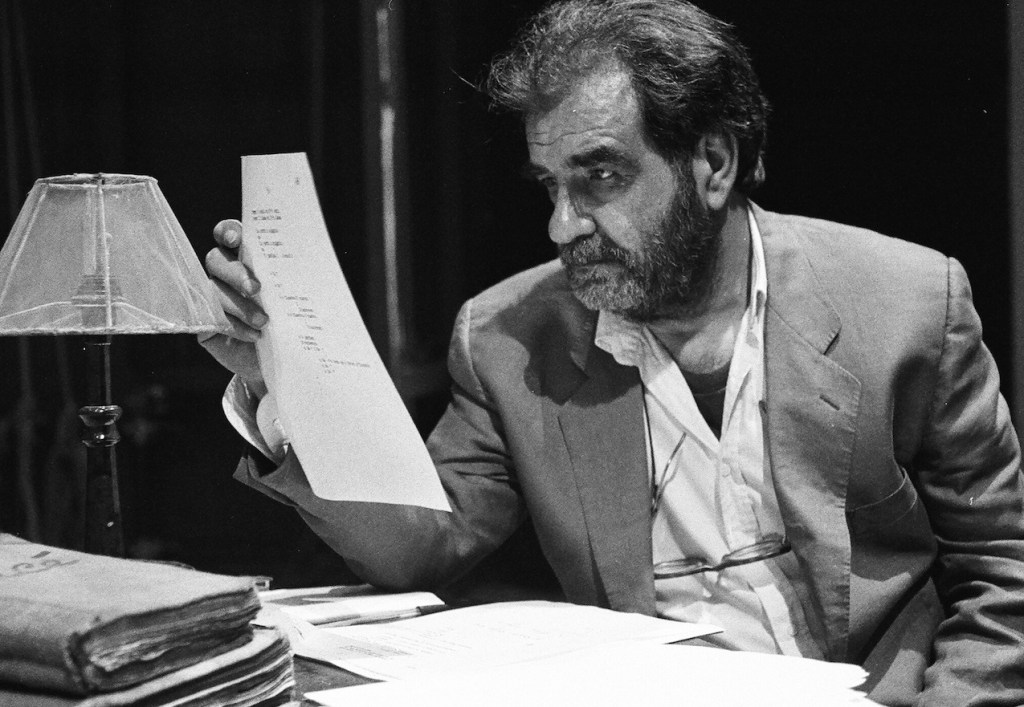
‘U campusantu è chinu. ‘Un ci nni vannu chiù,/ Morti… E i fannu arrivisciri.
Bastano questi versi, animati nella loro essenzialità dal sentimento tutto novecentesco dell’assurdo, per introdurre il mondo di Franco Scaldati, drammaturgo tra i più innovativi del teatro contemporaneo. Nato nel 1943 a Montelepre, piccolo comune vicino Palermo, si trasferisce ben presto nel capoluogo, dove frequenta le scuole elementari ed inizia a lavorare – a soli 12 anni – in una sartoria. In questo periodo legge tantissimo, da Dostoevskij alla beat generation, e matura il suo interesse per il teatro: una cultura disordinata che guida però il giovane Scaldati verso nuovi modelli estetici. L’esperienza inoltre lo identificherà per il resto della sua vita: veniva chiamato “il sarto”, una professione che rende metaforicamente il processo creativo dei suoi testi, come se i versi della sua vastissima produzione fossero dei ricami, un filo unico che – di volta in volta – si avvolge in decorazioni improvvise. Tra gli anni 70 e 80 allestisce i suoi spettacoli più noti (Il pozzo dei pazzi, Lucio, Assassina), seguendo un iter che si distacca dalle modalità del teatro stabile, che pone al centro dello spettacolo l’attore: Scaldati scriveva di mattina, e di sera le sue parole prendevano forma nell’esercizio costante del palco, fissate dalla voce e dai gesti di ogni attore, accresciute dalla loro improvvisazione. Il linguaggio della scena necessita il sacrificio di alcuni elementi letterari, compensati da altri pienamente teatrali, nel mistero di un’azione liturgica: sono gli attori che evocano, quasi moderni sciamani, le forze contenute in potenza nella pagina, le rendono più incisive tessendo – minuziosamente – le complesse relazioni che il testo si limita a suggerire.
Manca uno studio attento delle opere di Scaldati (alcune ancora inedite), ma se da una parte ciò si può imputare al cinismo di una società che emargina i suoi poeti, li dimentica consapevolmente nel meccanismo della sua auto-difesa, dall’altra bisogna ammettere che Scaldati è oggettivamente uno degli autori più insulari del teatro italiano. Partiamo dal tratto più caratteristico dei suoi testi, il dialetto palermitano: il critico tenta di intercettare un termine di confronto, di collegare l’oggetto del suo studio alla tradizione, ma ciò non è possibile, se non di sbieco. Di certo alla base di tutto c’è l’autore-attore delle vastasate, farse particolarmente in voga nei quartieri storici, e poi la strada da imboccare si fa incerta: il dialetto non è parte di un pastiche sperimentale, in linea con alcuni esiti della neo-avanguardia, né un semplice strumento di rappresentazione, di protesta contro la lingua standardizzata. La scelta linguistica di Scaldati è dettata da cause viscerali: al calcolo subentra l’istinto, con tutta la sua carica di passionalità. Se in De Filippo il napoletano, puntualmente amalgamato con le diverse varianti dell’italiano (regionale, popolare, standard), si configura come l’anello che lega la dimensione orale a quella scritta, la commedia dell’arte al teatro borghese, in un continuo e proficuo dialogo tra la cultura egemonica e quella subalterna; in Scaldati il palermitano risponde a dei fini esclusivamente poetici ed espressivi, rifiuta il compromesso per affinarsi, individuando nella propria violenza l’apertura per giungere – attraverso uno scrupoloso lavorio formale – alla poesia. Il palermitano era la prima lingua di Scaldati, ovvero quella imparata in famiglia, tra i vicoli del suo quartiere, ma soprattutto quella che parlavano i suoi sogni; e dunque il dialetto, invece di portare in scena una precisa realtà, la Palermo del dopoguerra, ne trae l’anima più segreta: scarnificata dalla memoria e dal sonno, la lingua si riduce all’osso, appuntita e lucente, cogliendo la musica di uno spazio puramente mentale.
Prenderemo in analisi una delle opere più esemplari di Scaldati, Lucio, spettacolo che segnò il passaggio da un teatro di favola ad uno di poesia: l’azione scenica, che progressivamente si riduce a favore della parola, ruota attorno una serie di coppie complementari, Pasquale senza gambe e Crocifisso che lo accudisce, i topi di pezza Ziù e Zié, il gobbo Lucio e la zoppa Illuminata, Ancilù e Ancilà; un’umanità degradata che vagabonda senza meta tra le macerie della civiltà, in uno spazio al confine tra l’inizio e la fine, il bene e il male. Una serie di quadretti, legati tra loro da fragili ripetizioni e simmetrie, si focalizza sulle necessità estemporanee di ogni personaggio: ciascuno tenta di soddisfare i propri bisogni fisiologici (mangiare, dormire, pisciare), e al tempo stesso s’interroga sulla realtà che lo circonda, anela alla pace interiore, ricorda ed inventa. Non accade nulla, la storia non va avanti, perché in questo mondo così ambiguo non può esistere storia, la sequela ordinata e logica degli eventi. Soltanto due forze, uguali e contrapposte, regolano la macchina teatrale: la tensione verso il basso e quella verso l’alto, per cui i personaggi sprofondano nel buio per poi risalire alla luce. Un’attitudine propria dell’arte barocca, che abbiamo già indagato nel caso di Lucio Piccolo: la realtà viene colta nel suo delirio materico, s’ingrandisce fino a farsi insostenibile, e nel mistero del notte s’intravede una risposta metafisica, il preambolo di un viaggio purificatorio. Il trauma è il momento di svolta dell’esistenza, accoglierlo in tutta la sua drammaticità significa liberarsi d’ogni sovrastruttura. Dalla prospettiva dell’assoluto nessun conflitto sembra insormontabile, anzi le parti in questione si mischiano, e si passa da una situazione al suo opposto senza accorgersene: si confondono soprattutto la morte e il sonno, e il passaggio non è mai irreversibile. Ad Ancilù basta accarezzare la testa di Pasquale per farlo resuscitare, e il miracolo avviene senza clamore: fase minima di un ciclo infinito, la morte perde il suo valore tragico, annulla le disgrazie e quieta l’anima, di conseguenza la sua sospensione non genera stupore. A ferire è il doppio potenziato della morte, ovvero quello stato di abbandono interiore che travolge i personaggi, l’incomprensione e la mancanza d’amore. Ed è proprio su queste due condizioni che si basa il più importante dispositivo teatrale, quel relativismo che porta Crocifisso e Pasquale a dialogare con effetti di comicità sgangherata, a volte pienamente assurda.
Crocifisso: ‘Abbassia, m’a runa un chilu i sasizza?
Pasquale: … un chilu i munnizza?
Crocifisso: … un chilu ri sasizza.
Pasquale: Iu ci pozzu rari un chilu i munnizza.
Crocifisso: Iu vogghiu un chilu i sasizza.
Pasquale: E iu ci pozzu rar’un chilu i munnizza.
Crocifisso: … E ch’i mi nni fazzu r’un chilu/ ri munnizza?
Pasquale: Si nni po fari sasizza.
Crocifisso: … ‘a’ ‘l’ura mi nni runa un chilu.
Scrutando il pozzo del dolore si scorge una nota di allegria, certamente violenta (litigi fisici e volgarità non mancano), e solo accettando un ordine sovrumano, questa tremenda verità presocratica, ci si prepara ad un ultimo, commosso, gesto d’amore. Così Pasquale, dopo aver svelato la sua massima sapienziale (Cu vuoli jri n’Paraddhisu, ru ‘nfern’av’a/ passari), si separa da Crocifisso non prima di avergli insegnato ad “abbanniare”, a richiamare secondo l’uso dei venditori ambulanti. Scaldati assimila la lezione di Beckett, ma non arriva alle stesse conclusioni: il sentimento del sacro conosce l’assurdo, trova il suo punto d’incastro nella modernità, per cui i personaggi non annullano la propria specificità in una lunga, e snervante, catatonia. Il desiderio tiranneggia, ma l’uomo può effettivamente ribaltare la sua carica negativa per abbracciare le forme più limpide della vita, ritrovare l’armonia della natura, del suo ritmo.
Crocifisso: Arrucav’u palluni.
Pasquale: I palluna arruccati si nn’acchiananu / ‘n’ cielu.
Crocifisso: … ‘n’celu ‘un c’è nienti/ … ci su i stiddhi.
Pasquale: … chiddhi ‘un su i stiddhi./ Chiddhi su tutti/ i/ pallun’arruccati.
Non una fuga in un paesaggio idilliaco, è bene ripeterlo: Scaldati si dimostra insofferente persino al modello del barocco, non esclude la realtà nella sua febbre d’amore. I prodigi, distinti dalle loro stranezze, sono sfuggenti come le figure di Bacon, e ricadono nella stessa concretezza plastica. L’esempio più adatto è Illuminata, la donna che assurge a paradigma della poetica di Scaldati: nella prima scena Lucio è impegnato a cantare la sua elegia per farsi perdonare la frequentazione della taverna, e se ammira i dentini d’oro, gli occhi di fata dell’amata, al tempo stesso la invita ossessivamente a non azzeccargli il coltello nella pancia. Così come dà la vita, la donna può dare la morte, e dunque si delinea come il personaggio più ambiguo del repertorio di Scaldati: Illuminata è il riflesso della luna, intesa come divinità archetipica (di cui è innamorato un secondo Lucio, un folle destinato a remare all’infinito), la sua figura è fissata in un altrove sublime alla maniera degli stilnovisti; ma questo non la sottrae alla sua sensualità, alla carne e ai suoi difetti (Illuminata è “sciancata”), anzi l’aspetto terreno dell’amore permane, si riverbera nell’angoscia dell’amante.
Lucio: Viri chi situazioni./ Viri chi mmruogghiu:/ mi vuol’ammazzari e senza r’ ‘iddha,/ ‘un pozzu campari.
Ogni personaggio sembra inseparabile dal suo doppio, talvolta quasi interscambiabile, e un coro a più voci subentra al singolo protagonista: il monologo è snaturato, l’uomo si rivolge sempre all’altro, in un dialogo a tratti senza risposta. Da notare però l’uso dei puntini di sospensione nel testo, quasi fossero i portali di un discorso singolo, di uno scambio che si accartoccia: ogni uomo contiene in sé l’altro, svuota di significato la colpa e il peccato. L’orizzonte si allarga a dismisura: se nell’umanità esistono gli assassini, tutti siamo colpevoli.
Ancilù: … nn’am’a spartiri.
Ancilà: … nn’am’a spartiri.
Ancilù: Picchì ‘un m’accumpagni, Ancilà?
Ancilà: … e po tu accumpagni a mia?!
Ancilù: … se.
Scaldati ha trasfigurato il microcosmo della sua infanzia, l’angulus capace di smontare – attraverso le sue contraddizioni – gli inutili manicheismi del teatro sociale, e partendo dalla miseria e dalla fame ha ricamato un canto di pace: la verità di questa musica così rigorosa ci sembra un monito nei confronti di una città che arranca nella direzione del progresso, fino ad apparire falsa.
L’oblio a cui è stato costretto fino ad ora il suo lavoro, la dice lunga – più che sul drammaturgo – su Palermo.